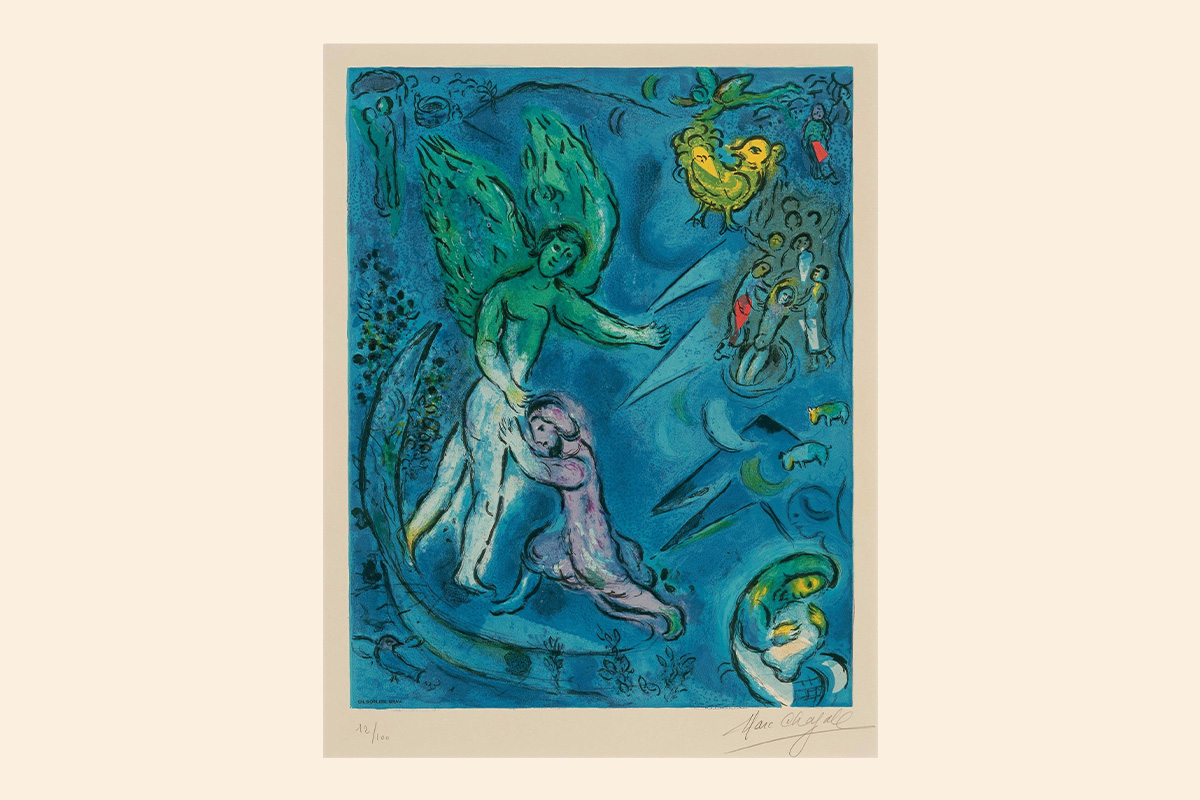
Tralasciamo, anche se l'autore lo considera brevemente, l'incontro tra due oggetti materiali, tra due piante, tra due animali, che in ogni caso segue leggi diverse a seconda dei rispettivi modi di essere.
Stiamo parlando di riunioneci viene detto che, correttamente quando un uomo entra in contatto con la realtà. Non è ancora un incontro se cerca solo, ad esempio, di soddisfare la sua fame, anche se può andare oltre l'istinto. Così come non è ancora un semplice scontro tra due persone.
Due condizioni iniziali per un incontro (personale), secondo Romano Guardini1) l'incontro con la realtà al di là di un'interazione semplicemente meccanica, biologica o psicologica; 2) stabilire una distanza realtà, per guardare la loro unicitàprendere posizione ad esso e di adottare un condotta pratica in merito.
Questo richiede libertà. Nella libertà, si possono vedere due lati: uno libertà materialeIl mondo è un luogo attraverso il quale possiamo entrare in relazione con tutto ciò che ci circonda; una libertà formalecome il potere di agire (o meno) a partire dalla propria energia iniziale. A volte la persona può giungere alla convinzione di non doversi fidare di tutto ciò che le si presenta: "Può chiudere le porte del suo cuore ed escludere il mondo. L'antica Stoa [scuola di stoicismo] faceva così, e questo è il comportamento dell'ascetismo religioso, per dirigere l'amore solo verso Dio" [1].
La riunione può iniziare solo a partire da da parte della personaAd esempio, di fronte a un oggetto che suscita il nostro interesse, come una fontana, un albero o un uccello, può diventare un'immagine di qualcosa di più profondo o addirittura aiutarci a comprendere radicalmente l'esistenza. Questo, a condizione che si superino l'abitudine, l'indifferenza o lo snobismo, la presunzione e l'autostima [2]. Questi sono i principali nemici dell'incontro.
Ma la riunione può anche essere bilaterale, e poi emerge una relazione speciale, in cui due persone si apprezzano reciprocamente in modo più profondo, al di là della loro semplice presenza o dei loro ruoli sociali: diventano un "tu".
Come contenuti della riunione Guardini elenca:
Inoltre, la riunione richiede che un buon momentoun momento propizio, composto da migliaia di elementi più o meno consci o inconsci: esperienze e immagini passate, energie e tensioni, esigenze, ambiente, stato d'animo, elementi creativi e affettivi, ecc. Da qui la difficoltà o l'impossibilità di compilare un incontro, e l'apertura dell'incontro per avvicinarsi alla Provvidenza e al destino.
La riunione richiede quindi, allo stesso tempo, libertà e spontaneitànel senso che si verifica solo se non viene cercato, come sarebbe l'incontro con un fiore blu che apre la strada al tesoro.
Il fenomeno dell'incontro può essere descritto dal suo lato metafisicoL'esperienza dei saggi lo testimonia: perché le cose sono così, come sono nate? Soprattutto, che le grandi cose devono essere regalonon sono applicabili e non possono essere forzati.
"Questo indica una creatività oggettiva che è al di sopra dell'individuo e dell'umano; un'istanza che dirige, condensa e 'scrive' la situazione con una saggezza e un'originalità di fronte alla cui sovranità le azioni umane sono sciocche ed elementari.
Per questo motivo, ogni incontro autentico risveglia il sentimento di trovarsi di fronte a qualcosa di immeritatoe anche di gratitudine o, almeno, di sorpresa per come tutto è andato curiosamente e bene.
Queste reazioni non devono essere sempre consapevoli, ma formano un atteggiamento (un elemento che, a seconda del risultato e delle circostanze, può diventare schiacciante" 3].
L'incontro può essere descritto, come fa anche Guardini, dal punto di vista psicologicoper l'incontro viene sottratto di fronte a ciò che chiamiamo concentrazioneL'incontro resiste alla ricerca dell'utile, del sistematico, del pedante e del diligente. L'incontro resiste alla ricerca dell'utile, del sistematico, del pedante e del diligente.
"Spesso gli incontri vengono regalati a persone che non si sforzano di ottenerli, che non sembrano nemmeno meritarli (la felicità)..." [4]. [4]. Si ritiene che sia stato un incroci dotati di libertà e necessitàSegue la curiosa sensazione che "non poteva essere altrimenti".
L'incontro ha, al terzo posto, rapporto con lo spirituale e il religioso, in quanto si tratta di una conquista o di un successo personale, grazie a un fattore che non deriva semplicemente dal lavoro o dalla lungimiranza umana, che potrebbe degenerare in pura abitudine senza gioia o emozione.
Questo fattore, pur rispettando la libertà, orienta l'esistenza verso una certa pienezzaD'altra parte, senza lasciare che diventi un'avventura instabile e un giocattolo del momento. Ecco perché l'incontro influisce sulla centro spirituale o all'interno della persona.
Questo è vero, sottolinea Guardini, "perché nell'incontro ciò che emerge non è solo l'essenziale e il singolare, ma anche l'essenziale e il singolare, l'essenziale e il singolare. mistero" [5]. "Nel momento in cui incontro una cosa o una persona, queste possono assumere una nuova dimensione, suora.
Allora tutto diventa un mistero; e questa è la risposta all'ammirazione, alla gratitudine, all'emozione". Guardini si riferisce all'evento narrato da Sant'AgostinoRacconta di come fu sollevato da un forte mal di denti dopo essersi affidato alle preghiere proprie e altrui (cfr. Confessioni, IX, 4, 12).

Per mostrare quello che ritiene essere "il nucleo del significato dell'incontro", Guardini si rivolge ad alcune parole di Gesù sulla strada per Gerusalemme. Vale la pena notare che queste parole hanno sempre un significato speciale per Guardini, perché sono legate a un momento trascendentale della sua vita, quando sperimentò una conversione sia intellettuale che spirituale [6]: "... una conversione sia intellettuale che spirituale".Chi desidera salvare la propria vita (psichevita o anima), la perderà; ma chi perderà la sua vita per causa mia, la troverà." (Mt 16:25).
Queste parole si riferiscono al modo di comportarsi dell'uomo nella sua relazione con Cristo e, secondo Guardini, sono chiavi di lettura dell'esistenza umana in generale. Significano: "Chi si aggrappa al proprio io lo perderà; chi lo perde per amore di Cristo lo trova" [7].
E Guardini spiega questa espressione un po' paradossale (dato che è perdersi cosa porta a un incontro): "L'uomo diventa se stesso liberandosi dal proprio egoismo. Ma non sotto forma di leggerezza, superficialità e vuoto esistenziale, bensì per amore di qualcosa che merita che per il suo bene si corra il rischio di non essere" [8].
Come ci si può liberare da se stessi in questo senso? Questo, risponde Guardini, può avvenire in molti modi diversi. Per esempio, di fronte a un alberoPosso semplicemente pensare di comprarlo, usarlo, eccetera, cioè la sua relazione con me. Ma posso anche considerarlo in un altro modo, in sé, contemplando la sua struttura, la sua bellezza, ecc.
Un altro esempio che Guardini fornisce è quello di due studenti Uno lavora pensando al suo futuro, alle sue opportunità, a ciò che può ottenere da questa materia o da quell'esame, e finirà per diventare un buon avvocato, un medico o altro. L'altro è interessato alle materie stesse, alla ricerca, alla verità, e può farne una carriera ragionevole.
Per la prima, la scienza è un mezzo per raggiungere un fine, che è quello di affermare se stessi nella vita. La seconda è aperta all'oggetto, mettendo al centro non se stesso, ma la verità. E si è realizzato da solo, man mano che il suo io cresceva in contatto con i progressi dei suoi approcci e della sua ricerca.
Altri esempi potrebbero servire, sottolinea Guardini, in relazione a amicizia y amore (amicizia calcolata e genuina; amore basato sull'appetito e sull'amore personale).
"L'amicizia nasce solo quando riconosco l'altro come persona.Riconosco la sua libertà di esistere nella sua identità e nella sua essenza; le permetto di diventare un centro di gravità a sé stante e di sperimentare una richiesta vivente affinché ciò avvenga davvero... Allora la forma e la struttura della relazione personale, e lo stato d'animo con cui la affronto, diventano uguali.
La relazione è centrata sull'altra persona. Rendendomi conto di questo, mi allontano continuamente da me stesso e mi ritrovo così, come amico, piuttosto che come sfruttatore; libero piuttosto che legato al mio profitto; veramente magnanimo, piuttosto che pieno di pretese"[ 9].
Guardini conclude la sua riflessione offrendo un'interpretazione conclusiva del significato ultimo dell'incontro, diremmo, alla luce di un'antropologia cristiana. È quindi importante come chiave per una pedagogia della fede.
Prima a livello antropologico. E poi, antropologico-teologico, in relazione alla rivelazione cristiana: "L'uomo è fatto in modo tale da manifestarsi in una forma iniziale, come un progetto. Se si aggrappa a quel progetto, rimane chiuso in se stesso e non passa alla resa, diventa sempre più stretto e meschino. Ha 'conservato la sua anima', ma ne ha perso sempre di più.
D'altra parte, se si apre, se si arrende a qualcosa, diventa un campo in cui l'altro può apparire. (il Paese che ama, il lavoro che serve, la persona a cui è legato, l'idea che lo ispira), e poi diventa sempre più profondamente e propriamente se stesso" [10]. Inoltre, nell'incontro con il mondo che lo circonda, l'uomo incarna ciò che è e crea, rendendo il mondo più profondo. cultura nel suo senso più ampio [11].
"Questa uscita da se stessi può diventare sempre più completa. Può raggiungere un intensità religiosa. Teniamo presente che il termine con cui si esprime una forma molto elevata di shock religioso è 'estasi', che significa proprio essere portati fuori di sé, essere fuori di sé.
Bisogna pensare che, come in tutte le relazioni, l'estasi non è unilaterale, cioè non riguarda solo la persona che esce da sé alla ricerca di colui che la incontra, ma anche colui che esce da sé; il suo essere esce dall'arcano del proprio sé. Si rivela, si apre" [12].
L'uomo diventa veramente uomo quando esce da sé rispondendo in eventi propriamente umani. Allora: "L'incontro è l'inizio di questo processoO almeno può esserlo.
Rappresenta il primo contatto con ciò che ci viene incontro, in virtù del quale l'individuo viene chiamato fuori dal suo io immediato e rinuncia al suo egoismo, incoraggiato ad andare oltre se stesso alla ricerca di ciò che gli viene incontro e gli si apre" [13].
Tutto questo può essere certamente educato nel senso di facilitato, incoraggiato, guidato attraverso una pedagogia dell'incontro.

Nei suoi scritti pedagogici, Guardini mostra il ruolo dell'incontro nell'educazione nel suo complesso. Sulla base di costituito dalla forma (struttura dell'esistenza personale concreta) che si dispiega nella "formazione con l'aiuto dell'educazione, la persona si realizza anche grazie all'incontro, nel mezzo del movimento del divenire e della molteplicità delle sue fasi nella diversità dei fattori del proprio essere e nella pluralità delle sue determinazioni" [14].
Tutto questo fa parte della pedagogia del aspetto soggettivo o immanente della persona.
A questo va aggiunto il aspetto oggettivo o trascendente della persona (in relazione a idee, norme e valori: la realtà, il mondo, le persone, la storia, la cultura, Dio, la Chiesa, eccetera, che valgono in sé e non principalmente per il loro significato per me).
Quest'ultima è realizzata attraverso la pedagogia della accettazione (accettazione dell'obiettivo, così com'è) e del servizio (arrendermi a ciò che la realtà mi chiede)[15]. In questo aspetto trascendente, dirà Guardini, è fondato dignità umana.
L'educazione deve insegnare su discernimento quale dovrebbe essere il centro di gravità di ogni azione personale, tenendo conto dell'insieme: la forma personale, l'incontro o il servizio. Insegnare a prendere queste decisioni con vera libertà: questo è il senso della pedagogia.
RIFERIMENTI:
(*) Cfr. R. Guardini, "L'incontro" in Id, Etica. Conferenze all'Università di Monaco (testi raccolti dal 1950 al 1962), BAC, Madrid 1999 (originale tedesco 1993), pp. 186-197; Id., "L'incontro" (saggio pubblicato in tedesco nel 1955), in Id, Persona e libertà. Saggi di fondazione della teoria pedagogica, a cura di C. Fedeli, ed. La Scuola, Brescia 1987, pp. 27-47.
[1] Persona e libertà, 32.
[2] Cfr. ibidem, 34.
[3] Etica, p. 192.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem, 193.
[6] Cfr. https://iglesiaynuevaevangelizacion.blogspot.com/2018/10/50-aniversario-de-romano-guardini.html.
[7] Eticao. c., o. c., p. 194.
[8] Ibidem, 195. A questo proposito, vale la pena ricordare ciò che il Concilio Vaticano II ha detto dieci anni dopo, in Gaudium et spes, 24: "L'uomo, l'unica creatura sulla terra che Dio ha amato per se stesso, può trovare la propria realizzazione solo nel dono sincero di se stesso agli altri".
[9] Persona e libertà, 45.
[10] Etica, 196.
[11] Cfr. Guardini, I fondamenti della teoria della formazioneEunsaPamplona 2020, 51s.
[12] EticaQuesto è stato il caso, infatti, della Rivelazione cristiana (in cui Dio si comunica all'uomo) e, in un altro modo, di ogni autentica consapevolezza della propria vocazione.
[13] Etica., 197.
[14] I fondamenti della teoria della formazione, 80s.
[15] Cfr. ibidem, 82-88.
Sig. Ramiro Pellitero IglesiasProfessore di Teologia Pastorale presso la Facoltà di Teologia dell'Università di Navarra.
Pubblicato nel suo blog Iglesia y nueva evangelización.